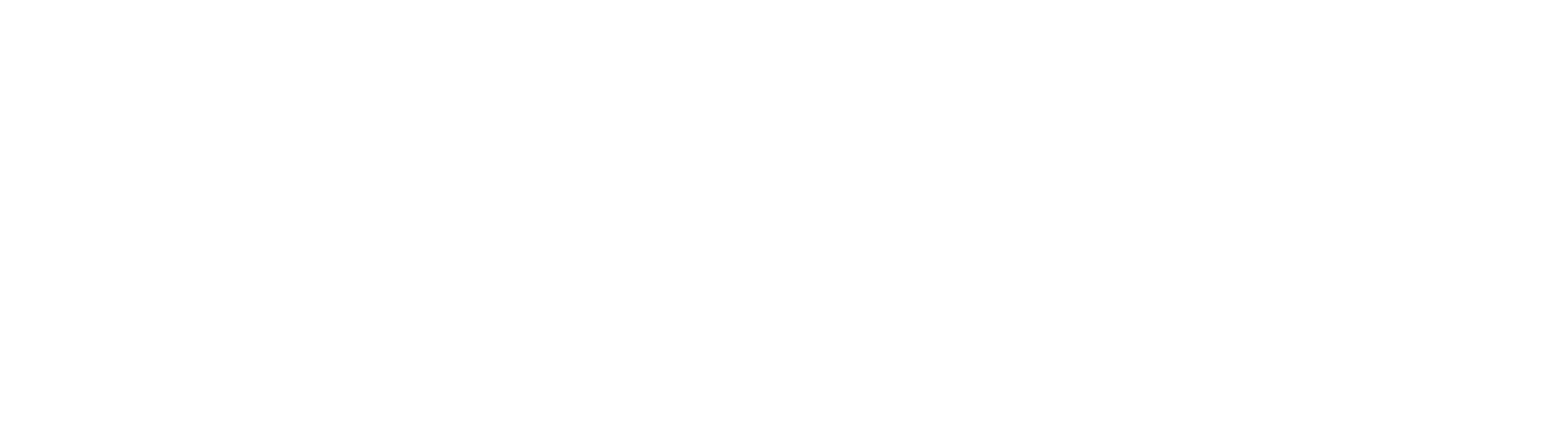Un violino di Lanaro per il compagno Negri
di VINCE B
Per quanto in un libro abbia letto:
Ritenere un nemico dovrai
chi ti loderà al tuo cospetto,
nondimeno, io credo che mai
uomo sincero abbia celato
in fondo al suo cuore un gran bene
senza averlo dovunque mostrato:
si deve del bene dir bene
François Villon
Ecco il Wilhelm Meister del secolo venti, dopo anni di apprendimento e peregrinazioni, stavolta risoluto nel rompere con la modernità borghese, Dedalus veneto che si affranca dall’ipocrita gabbia degli istituti cattolici e statuali, il cavalleggero rosso, Babel’ redivivo, scienziato nel turbine della rivoluzione.
Storia di un comunista di Toni Negri è un romanzo di formazione, di modificazione e di azione, nuove Confessioni di un ottuagenario e come quelle di Nievo, illustre concittadino del nostro eroe, diario di quarant’anni di vita personale e collettiva, contro il potere costituito per un repubblicanesimo assoluto.
Si scherza a romanzare, ma «quando il realismo è comunista, il romanzo conclude alla lotta» (234) e queste memorie, ricordo che non rispecchia ma ritrova, fanno pensare a quelle del rivoluzionario e comunardo Jules Vallès: dal dolore dell’infanzia alla gioia del conflitto.
E poi oltre verso una vita filosofica che contro-effettua gli eventi: «Oggi, di nuovo, invecchiando, ritrovo la fertilità delle ore del mattino. Svegliandomi presto, senza alzarmi da letto, programmo le giornate da vivere tanto intensamente che quasi tutto, poi, sembra previsto. E anche gli eventi inattesi, quando ti prepari in quella condizione, riescono a non farti male. Controluce, fino alla mattina successiva, molto presto» (26).
Prima però c’è la sofferenza, l’ombra della differenza, i buchi neri, un esausto di Sam Beckett: «Sogno spesso, in quegli anni, di vivere immobile, chiuso in una stanza, steso su un letto, guardando il mondo attraverso la televisione» (47). Siamo stati tutti, in qualche modo, almeno una volta hikikomori. Ma nel frattempo si vive, si scopre che non siamo creati ma creatori e si scopre nel fare insieme, le soglie trascorrono, fino alla definizione del proprio gesto: agire la tendenza per l’agitazione. «Emancipatevi, poi vi libererete: vergogna! Non ci sono stadi di sviluppo per la volontà di liberazione» (218). Vogliamo tutto.
Dopo la debacle degli uomini senza qualità, è il momento della Fuga senza fine di Joseph Roth da qualsiasi europa immaginata: alla ricerca dell’ignoto, al disegno di nuove contrade, per disinnescare il nodo gordiano e divenire buoni europei. Per farlo bisogna pensare altrimenti come Foucault e Deleuze-Guattari e vedere altrimenti come i cristalli distanti di Huillet-Straub e le arts & crafts di Berger, l’esperimento di Negri è il chiasma che aggiunge – in un rimando costante – l’associazione delle singolarità all’associazione di emozioni e di nozioni: così va il mondo, eticamente.
E così procede il libro, pipeline: blocchi di affetti, lasse di lotta, dolci e nitidi ritratti di militanti. Parlano libri, documenti, riviste, volantini, parlano fabbriche e metropoli, parlano i progetti collettivi. C’è la passione per l’arte e il rapporto con il dopoguerra più interessante: Enzo Paci, Delio Cantimori e tanti altri. E ci sono le fotografie dure ed esatte delle capitali perdute o mancate – Napoli,[1] Roma[2], Milano[3] – con quella voglia di cambiare, quell’amor di patria gappista con cui gli operai massa riprendevano i fili delle grandi lotte proletarie nel meridione di Peppino Di Vittorio e Danilo Dolci (cosa resta di queste nobili tradizioni? enormi strutture, alcuni buoni propositi, opere meritorie, ma in definitiva molta buona volontà e tanta cattiva coscienza, e pure non manca mai il caso per volgere al meglio).
Encyclopédie degli operaisti, questi nostri antenati, qui si dà conto di quel movimento centrifugo messo in campo nella società italiana (risalta l’ampio spazio dedicato alla rivista Critica del diritto, per una discussione da riaprire) e del dialogo con tedeschi, francesi e statunitensi, l’operaismo non fu per un attimo provinciale e già dall’inizio provincializzato nel contatto con le esperienze più ricche dell’eterodossia marxista: Socialisme ou barbarie, la Johnson-Forest Tendency e specialmente le ricerche di E. P. Thompson, G.P. Rawick e K. H. Roth, che con doppio nome mostravano il doppio senso della produzione di soggettività, che la violenza dell’accumulazione giace subito e di continuo sui modi di vivere comuni.
Si scoverà una vena ilare: i giudizi tranchant su “Francoforte” e “Budapest”, la missione globale dell’uomo europeo (195), l’innocenza nell’affrontare i rapporti di genere nel collettivo: «in ogni caso: omnia munda mundis» (282). Quanto è lontano chi proviene dall’operaismo dai torvi e attoniti gauchistes – godetevi un apologo esilarante sulla misurazione del valore secondo la burocratjia sindacale.[4]
Raccontare contenti i ‘60 e ‘70 in Italia, via dal grigio e nostalgico antiquariato, Storia di un comunista è storia di comunisti, monumentale e corale. Non c’è inciampo, è turbamento: riconoscere ex post la grandezza di un intellettuale è concesso se non auspicabile, ciò che il potere non può accettare è la polifonia, tanti anni di lotta di classe, quanta paura per i padroni. L’isterismo è una buona notizia: lo spettro gli guasta il sonno.
Roberto Bolaño, cantore di una generazione perduta e di una che verrà, si rammaricava per la disperata ricerca di rispettabilità degli scrittori cileni e celebrando l’ironia di una vita malandrina, diceva: «per scrivere bisogna collocarsi nella posizione che Villon, il poeta medievale francese, consigliava, quella del fuorilegge. Si scrive al di fuori della legge. Sempre. Si scrive contro la legge, non dalla parte della legge». Poco male per teste e città piccolissime. Eppure ci muoviamo. Così non sarà più. Allora l’angelo nuovo se la ride, lo sapeva Fuser Guevara, lo sa ogni danzatore e danzatrice della palla ovale (chiedete a Marco Mono!): guardando indietro, si avanza, per puntare alla meta.
Concluso il libro, il nostro personaggio voltairiano, un po’ Candide un po’ Pangloss, dopo innumerevoli e avventurose peripezie, tornerà a coltivare il campo della filosofia, gli umbratili ‘80, durante le sue prigioni – maledette mai abbastanza – e poi ghibellin fuggiasco, saranno dedicati al ripensamento del materialismo con tre capolavori teoretici, con tre intercessori delicati ma quanto forti: Spinoza e un puro di piano di immanenza che sostanzia il progetto di liberazione, Leopardi e la costruzione di umani ponti di essere sul precipizio del nulla, Giobbe e l’incommensurabile eccedenza dell’attività. Ritrovando così il senso e la ragione del desiderio comunista. Traiettoria certa portata avanti senza posa.
Perciò c’è tanta attesa per una nuova opera, magari sul pensiero vivente italiano, sono tanti i nomi che tornano in questo libro, ma sopra tutti quello di Gramsci, ancora un’infrangibile fragilità, per completare un lavoro iniziato: «Quel Gramsci, sul bordo dell’occupazione fascista dello Stato, al limite fra rivolta e repressione: il gobbo Gramsci assomigliò all’asmatico Che. Avevo cominciato a leggere alla mia maniera tutto Gramsci, ma la lettura fu interrotta – peccato! Alla fine degli anni Settanta avevo avuto netta l’impressione che fosse possibile rileggere Gramsci in maniera nuova, nel mezzo della dialettica fra lavoro morto (la Fiat, il Risorgimento, lo Stato monarchico, la Grande guerra e il fascismo) e il lavoro vivo (la classe operaia torinese, le lotte socialiste e comuniste, la rivoluzione sovietica): un seguito di lotte e discontinuità capaci di configurare una realtà corrispondente al dispositivo teorico che perseguivo» (305).
Intanto, sparso tra queste pagine si può rintracciare un inedito opuscolo negriano su Alquati e la conricerca, su quel pioniere avveniristico e la sua scoperta di una scienza adeguata di classe (da leggersi davvero assieme a “Spinoza: una sociologia degli affetti” in Spinoza e noi), di quel «conoscere attraverso il fare» (203), perché «l’inchiesta si vuole in movimento, la conricerca è organizzazione» (207). Come si fa, by Marx:
«Dalla costituzione materiale su, verso la composizione politica di classe, secondo il metodo operaista; ma nello stesso tempo giù, dall’analisi capitalista delle nuove forme di controllo di una società disgregata ai processi e ai movimenti di autovalorizzazione di un nuovo proletariato che opera nella fabbrica sociale. Chiaro che questo sforzo teorico è difficile quando si è sotto attacco, e ogni analisi che tenti di esprimere la materialità dell’esistenza di classe è denunciata come “apologia dell’immediatezza”. Quel che infastidisce è che chi promuove questa polemica (fondata sull’“autonomia del politico”) lo fa per signoreggiare su quell’immediatezza dell’esperienza che noi vogliamo invece rivivere. E non c’è nulla di torbido in questo rivivere: “non parliamo tedesco, parliamo inglese”, scrivo allora, intendendo che si può ripartire non dalla mediazione, dalla dialettica, ma solo da una politica della differenza, come tentativo di costruzione di un nuovo che non ripeta la gestione del vecchio. E che mi sembrano felici quei paesi e quelle lingue dove vivere l’immediatezza non è una cosa sporca» (594).
Il macchinoso movimento operaio ufficiale si andava esaurendo già mezzo secolo fa, stella morta rimasta accesa, precipitando sparge detriti sulle teste o più che altro sulle scarpe. Ma non è certo un problema preferire Weimar all’Ottobre, per dirla con una boutade, ovvero un’espansiva apertura democratica alla costruzione di autonomia e all’orizzonte di rottura, è legittimo, una scelta ragionevole e di buon senso, basta dirlo, se è vero che il parlar chiaro è prerogativa anche dei consiglieri dei governanti.
Diversamente, con intensità dentro la composizione sociale producendo sapere e soggettività, analizzando estesamente la composizione del capitale, l’assiomatica capitalistica, non per mimarla con una proposta un pochino bislacca e un tantino arrogante di governance delle lotte, ma per distruggerla: per liberare il lavoro vivo dalla cattura del lavoro astratto, per organizzarlo in una topica delle istituzioni comuni capace di conquistare terreno e aumentarne la potenza (viceversa ogni tipo di richiesta di riconoscimento neo-comunalista finisce per essere vetero-corporativa, rischiando di restare un’idea bella per anime belle; e d’altro canto, la fin de ciclo latinoamericano insegna quanto sia scivoloso legare, seppure pattiziamente, l’autorganizzazione allo stato e che in ogni caso il patto viene rotto dall’infedeltà delle soggettività). Contro l’assiomatica capitalistica inventare una diagrammatica rivoluzionaria, intrecciando conricerca e trasduzione: «Quanto erano simili Alquati e Guattari per questa loro capacità di scoprire e, insieme, dare direzione, soggettivare le più varie forme di agencements collectifs e dirigerle verso un nemico – il capitalismo come macchina di sfruttamento!» (213).
Ora, che con lo sfinimento dei centri sociali è sfumata l’ipotesi che potessero farsi camere del lavoro precario e mentre nel cosiddetto movimento fa strage la «vecchia malattia anarchica del pressappochismo, della religione dell’indignazione e del dilettantismo organizzativo» (586), ci si domanda quali possano essere le soluzioni al problema dell’organizzazione, la prima risposta al che fare, cogliendo gli inviti a studiare per prendere posizione e farne conseguenza, sarà: Sperimentare, sperimentare e ancora sperimentare! Quando la lingua diventa di legno è tempo di ardere e immaginarne una nuova. Per un nuovo assalto al cielo – quando ci sono da nominare e usare più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la nostra filosofia – il cattivo magistero di Toni Negri sarà lieto e salutare, l’archivio operaista fucina di pezzi da assemblare, per cattivi discenti che ne facciano non riserva aurea ma sorgente e bussola, per l’intelletto degli operai sociali, in salvo dalla dottrina degli operai della filosofia. Questo è un libro da regalare alle cabezas pensantes, per chi ne sa e ne fa, scorpioni e felici come il giovanissimo Marx, ma pure a los padres perché si avveri il sogno di Tobia: un balsamo per gli occhi, per guardarsi in un incontro tra liberi ed eguali. Con l’augurio che questo limbo di frustrazione e disillusione si trasformi in differenza, ira e amore.
[1] «E Napoli? Quel triangolo fra il Duomo, San Domenico e il mare mi è sufficiente. Percorrendo Spaccanapoli, è come se attraversassi il Mediterraneo antico e moderno, un bailamme di civiltà – perché quella miseria proletaria napoletana era oltremodo civile. Per il resto, la borghesia napoletana non mi interessa: apprezzo il barocco dell’architettura, molto meno il barocco borghese dei rapporti sociali. Scopro che a Napoli il nero predomina sul chiaro, il pessimismo sull’allegria, la tradizione, l’egoismo, l’avarizia sulla modernità, la socievolezza e la generosità, fra i borghesi coltivati che hanno un certo peso (e pretendono di rappresentare la maggioranza proletaria) e le camorre che dominano la città» (131).
[2] «A Roma risuonano tutti i movimenti, ma non capitano mai le lotte: l’ontologia della lotta di classe sta sempre altrove, a Roma ne arrivano talvolta i simulacri. È una capitale diversa da Parigi o Londra, dove le cose avvengono» (251).
[3] «A Milano si sbatte contro una sorta di orgoglio operaio delle esperienze, della memoria di lotta e della pratica di organizzazione che presto si trasforma in autosufficienza e gelosia» (361).
[4] «Lo dico con ironia: mi ha sempre colpito lo sforzo di sindacalisti e padroni per dare un prezzo al lavoro. Li immaginavo far sforzi di misurazione, i padroni con il moltiplicatore di milioni, i sindacalisti con le percentuali e i decimali. Una rivendicazione salariale nasceva sempre da queste operazioni: i sindacalisti si presentavano agli operai come matematici, più che come delegati a rappresentarli. L’obiettivo sindacale doveva avere, secondo loro, una parvenza «scientifica» (sic): perciò poteva essere modificabile solo se fosse stato scoperto un errore di calcolo (cioè di misurazione). Nel sindacalista doveva brillare qualche gemma trascendentale, fosse scientifica o magica. Ne ridevano gli uomini più intelligenti, adattatisi alla funzione sindacale: Bruno Trentin e Pierre Carniti mi raccontarono di frequenti incidenti di percorso nel tentare la misurazione. Non c’era invece alcuna ironia nei mestieranti nei quali c’imbattemmo durante le lotte a Marghera. In genere arrivavano alle porte della fabbrica nell’ora di mensa, con Gazzettino, Corriere della Sera e Sole 24 Ore – l’Unità era facoltativa – sottobraccio, e ti raccontavano di aver passato la notte a studiare le ultime tabelle. Costo del lavoro, liste dei profitti, buste paga, cartelle delle imposte? Non specificavano. Se qualcuno gli chiedeva se mai avevano avuto il sospetto che quella magica misura fosse la semplice cifra dello sfruttamento del padrone sulla pelle dell’operaio, ti guardavano come si guarda un deficiente. C’è da dire che spesso, quando si studia l’economia classica, si ha l’impressione che sia stata inventata per legittimare lo sdegno del sindacalista indebitamente contraddetto, quando gli si contesta la possibilità di un contratto «scientifico» da imporre all’operaio. Spesso anche il Diamat ti lascia quest’impressione. Con Keynes le cose cominciano a essere un po’ diverse: la grande magia di costruzione del valore del lavoro comincia a implicare la moneta, la sua dimensione sociale come cassa nella quale risuonano i bisogni dei poveri, e qui l’inganno della misurazione lascia spazio al miracolo politico delle compatibilità e dell’equilibrio degli interessi in lotta. Se riuscivi a spiegarlo al sindacalista, subito replicava: ma vai all’università a spiegare queste cose, noi siamo operai, non intellettuali! E va bene – allora prendetele nel culo queste 5.000 lire uguali per tutti, dove più che per i padroni quell’uguale per tutti sembrava insultante per i sindacalisti. L’anno successivo, quando imponemmo aumenti eguali per tutti alla Fiat, lo scandalo fra i sindacalisti – non importa di che colore – fu immane! Non andavamo contro i padroni, ma contro la scienza: la misura del valore è verità indiscutibile che, come ogni assoluto, solo i sacerdoti possono interpretare!» (324-5).