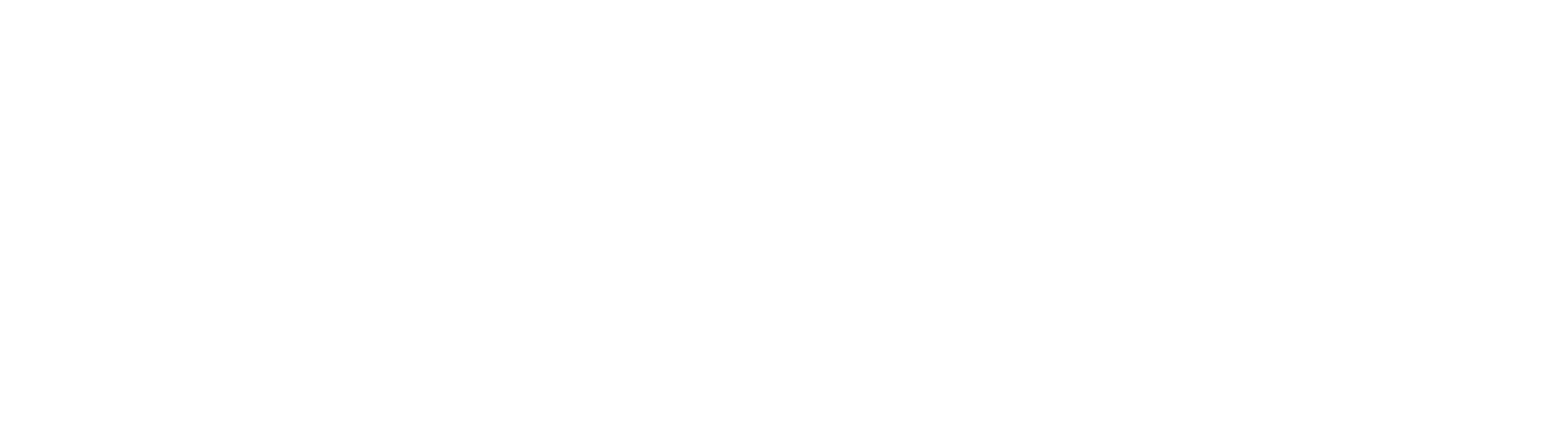Il punto di vista precario
di DAVIDE GALLO LASSERE
“Welcome to the jungle, benvenuti nella giungla della precarietà”. Così si apre il primo editoriale del primo numero dei Quaderni di San Precario, la rivista nata nel 2010 dall’incontro tra le pratiche comunicative e conflittuali ispirate dal movimento di San Precario e le riflessioni di attivisti, avvocati e ricercatori ruotanti attorno all’ex collettivo UniNomade. L’obiettivo dei Quaderni, i quali s’inscrivono all’interno di un percorso ventennale di mobilitazioni, consiste infatti nel dichiarato tentativo di “sviluppare un discorso precario, come punto di vista di una soggettività politica attivamente precaria”. Questa breve citazione racchiude le due caratteristiche principali che specificano la pratica discorsiva del periodico: l’irriducibile parzialità della propria prospettiva e la rivendicazione esplicita della condizione particolare in cui si radica tale parzialità. Da qui l’urgenza di esprimere autonomamente la propria voce, aldilà dei sindacati confederali e dei partiti più o meno sinistrati, a cui “mancano letteralmente le parole del vocabolario per poter rappresentare i lavoratori precari”. I discorsi precari – di cui la Piccola enciclopedia precaria appena edita da AgenziaX a cura di Cristina Morini e Paolo Vignola costituisce un ottimo prontuario – “non rappresentano i lavoratori senza contratto a tempo indeterminato, le nuove partite iva o i disoccupati, bensì sono ciò che fa lo stesso precario, nel duplice e simultaneo senso del fare: sono discorsi costruiti, sviluppati e veicolati dai precari e al tempo stesso tali discorsi costruiscono la soggettività precaria”. L’intento performativo dei Quaderni risiede dunque nella volontà di forgiare delle nuove armi critiche che possano contribuire all’articolazione di un punto di vista conflittuale sulla precarizzazione esistenziale e lavorativa del capitalismo odierno; nel raccontare, tramite la pratica dell’inchiesta, della con-ricerca e dell’auto-inchiesta, le esperienze e i vissuti quotidiani dei lavoratori e delle lavoratrici al fine di promuovere la “ricomposizione di ciò che viene frammentato dalla precarietà”; e nel riportare infine le cause e le sentenze giuridiche favorevoli a questi ultimi fornendo così “degli attrezzi di ‘sapere precario’” volti a incentivare l’attivazione di pratiche politiche “dentro e contro” tale condizione.
La generalizzazione della precarietà non deve infatti essere ritenuta il semplice esito dell’imposizione dall’alto di un regime di vita sfavorevole a chi è costretto a guadagnarsi il necessario sul mercato del lavoro. Certo, a partire dagli anni 70 si sono via via sperimentate e dispiegate molte riforme tecnocratiche e manageriali volte a replicare all’ingovernabilità crescente del sociale – dall’ambito monetario e finanziario fino a quello lavorativo, passando per tutta una serie di metodi ancor meno idillici di quelli che da sempre regnano nell’economia politica. Ma sono state le lotte dal basso, per prime, a far saltare il coperchio del vecchio modo di regolazione keynesiano-fordista, a rimettere in causa la norma del lavoro salariato e a liquidare in modo risoluto l’ideologia disciplinare dell’impiego stabile e fisso. Il desiderio di autonomia e di auto-determinazione, il bisogno di realizzarsi oltre e non solo dentro il lavoro hanno giocato un ruolo decisivo in tale vicenda. E sono pertanto da rivendicarsi in tutto e per tutto come tali. Essi sono presenti nel rifiuto operaio del lavoro dipendente, così come risuonano a chiare lettere nelle parole d’ordine “più salario e meno lavoro”, “aumenti salariali sganciati dalla produttività”, o, ancora, “salario contro il lavoro domestico”, “salario studentesco”, etc. La critica dell’autorità e della gerarchia – di fabbrica, di genere e generazione –, la rivolta contro ogni tipo di subordinazione, di accentramento decisionale e di prescrizione, l’opposizione nei confronti del comando su tempi, luoghi e attività da svolgere non solo affonda il proprio riconoscimento in una storia che, per dirla col Marx dell’accumulazione originaria, rimane “scritta negli annali dell’umanità a caratteri di sangue e fuoco”, ma ha anche condotto all’istituzione positiva di nuovi legami interpersonali, di forme e stili di vita inediti, di immaginari, valori e relazioni sociali liberati dal moralismo e dall’ascetismo così tipici di molte traiettorie biografiche lineari e del tutto prive di interruzioni o di significativi cambiamenti di fase. Queste alcune delle istanze di auto-emancipazione che il progressivo acuirsi della crisi tende sempre più a impossibilitare o, peggio ancora, a strumentalizzare a suo vantaggio.
È dal combinarsi di questo doppio movimento – attivo e proveniente dal basso il primo, re-attivo e calato dall’alto il secondo – che si sono verificate quelle trasformazioni sociali di ampia portata che hanno affossato il vecchio regime d’accumulazione e che sono culminate nello scoppio della crisi del 2008. Alcune voci della Piccola enciclopedia precaria ci aiutano a svelarne l’arcano: “bioeconomia e capitalismo cognitivo”, “moneta”, “trappola della precarietà”, “ricatto al futuro”, “rendita versus profitto”, “debito”, “fabbrica della paura”, “poliziotto”. Ciò che altri lemmi raccolti nel volume non dimenticano di scandagliare, invece, è il rovescio della medaglia, ossia le potenzialità immanenti a questa nuova configurazione storico-sociale: “processi costituenti”, “comune”, “comun(e)ismo”, “eccedenza”, “riproduzione sociale”, “sapere vivo”, “diritto all’insolvenza”, “sciopero precario”, “reddito sociale garantito come reddito primario”, “potere in comune”. Altrettanto preziose, poi, diverse entrate volte a disinnescare le illusioni inerenti a dei feticci sempre più ideologizzati: “creatività”, “lavoro gratuito ed economia dell’evento”, “ricercatore: il mestiere più bello del mondo”, “i sogni infranti dei free lance”, “precario-impresa e cartolarizzazione”, “in odio alla meritocrazia”, “lavori inutili”.
Due nozioni, infine, portate alla ribalta dalla crisi, mi paiono suggellare lo sforzo collettivo che si compendia in questo agile libro, siglando l’ingresso in una nuova fase in cui il lato oscuro attinente alla precarietà ha preso decisamente il sopravvento su quello legato al suo potenziale emancipatorio.La prima, “impermanenza”, sonda lo stato di transizione insistente tale per cui ognuno di noi si ritrova (a prescindere dal contratto di cui dispone) sempre più esposto agli andamenti alterni della valorizzazione del capitale, della ricerca incessante del profitto e della governabilità dei processi socio-economici. L’altra, “Kill the Poor”, ci ricorda come una larga fetta di popolazione costituisca ormai un semplice costo di riproduzione (sussidi, aiuti, welfare), il quale, oltre a non recare alcun vantaggio economico o politico, pone dei seri rischi in termini di insubordinazione: nemmeno più “esercito industriale di riserva”, questo sovrappiù umano può pertanto essere eliminato fisicamente senza nessun problema (do you remeber la Grecia, Ferguson, i migranti, le Favelas, le banlieue etc. etc.?). Come già accennato all’inizio, a questa infame critica delle armi, la Piccola enciclopedia precaria risponde affilando le armi delle critica: le parole, infatti, “quando sono critiche, si trasformano in pietre e San Precario ama sedersi su un grosso cumulo per esserne provvisto al momento opportuno”. Ciò non è sicuramente sufficiente, ne siamo consapevoli. Ma non bisogna temere: ce n’est qu’un début…